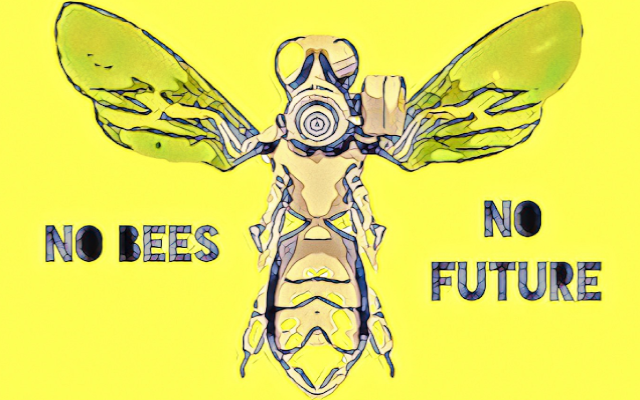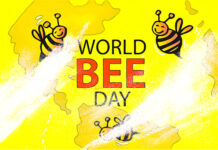I pesticidi sono la prima causa dello sterminio in corso di api, farfalle e altri insetti impollinatori. E i cittadini europei reagiscono con l’iniziativa ‘Salviamo le api’, registrata dalla Commissione europea il 15.5.19. Che dovrà raccogliere 1 milione di firme in almeno 7 Paesi membri, nei 12 mesi a seguire. Ecco perché.
Pesticidi e api, relazioni pericolose
Il Colony Collapse Disorder (CDD) – fenomeno che comporta la perdita di orientamento nelle colonie di insetti, così destinati a morire – è stato registrato dapprima negli USA, ove l’agricoltura intensiva fa largo utilizzo di agrotossici. Il flagello delle api mellifere, con perdite variabili tra il 50 e il 90%, è stato dapprima attribuito a una combinazione di fattori. Pesticidi, acari, funghi e virus. La ricerca scientifica ha poi identificato una relazione causale diretta tra l’esposizione degli insetti impollinatori ai pesticidi neonicotinoidi e il CDD. Api, farfalle e molte altre specie non sono in effetti il bersaglio principale di tali sostanze, che tuttavia ne colpiscono il sistema nervoso centrale. Provocando paralisi e perdita delle funzioni mnemoniche e di orientamento. Oltre a danni alla riproduzione e indebolimento generale, con minore capacità di resistere alle malattie.
I neonicotinoidi sono un gruppo di sostanze di sintesi chimica la cui struttura è simile alla nicotina. Esercitano un’attrazione simile a quella della nicotina nell’uomo, con effetti 10.000 volte più dannosi per gli impollinatori rispetto ad altri pesticidi. Sono stati introdotti a metà degli anni ‘90 quali alternative agli agrotossici ‘classici’ – es. DDT, HCH – proprio in virtù del loro minor impatto sull’ecosistema. Almeno in apparenza, fino a quando anch’essi hanno rivelato il concreto effetto di provocare l’estinzione di quelle specie di insetti da cui dipende l’impollinazione dei 3/4 delle colture a livello planetario.
L’Environment Protection Agency (EPA, USA) ha altresì raccolto prove scientifiche sull’elevata tossicità per le api di diversi altri gruppi di pesticidi, tra i quali gli organofosfati e i piretroidi (ampiamente utilizzati anche per combattere le zanzare). Senza tuttavia adottare misure concrete fino a maggio 2019, quando 13 neonics sono stati esclusi dal Federal Register degli insetticidi ammessi in agricoltura. A esito di una trattativa con il Center for Food Safety, che nel lontano 2013 aveva avviato un’azione legale insieme a diverse ONG e a quattro apicoltori. I neonicotinoidi rappresentano peraltro a tutt’oggi circa un terzo dei pesticides venduti nel pianeta. Laddove l’agrotossico più venduto al mondo, il glifosate, si è a sua volta rivelato pericoloso (anche) per gli apoidei, di cui altera il microbioma.
Neonicotinoidi, valutazione del rischio e misure restrittive
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), a febbraio 2018, ha rivisto le proprie precedenti valutazioni su tre neonics (clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam). Affermandone la concreta pericolosità per la sopravvivenza delle popolazioni apistiche. L’Unione europea ha successivamente introdotto il divieto d’impiego di tali sostanze nei campi aperti – non anche in serra – a decorrere dal 19.12.18.
La Francia è andata oltre, estendendo il divieto a ogni impiego agricolo (incluse le coltivazioni in serra) e ad altri due neonicotinoidi (thiacloprid e acetamiprid). A decorrere dall’1.9.18, fatta salva l’ipotesi di concedere deroghe transitorie a singoli operatori, per il solo acetamiprid, fino all’1.7.20. Nel contesto di un più ampio programma nazionale di riduzione progressiva degli agrotossici, a partire da quelli ad ampio spettro (es. glifosate). Sulla base delle valutazioni espresse dalle Agenzie nazionali per la sicurezza alimentare (ANSES) e per la ricerca in agricoltura. La quale ultima ha dimostrato come alla drastica riduzione d’impiego dei pesticidi non corrisponda alcun effettivo pregiudizio alla produttività agricola.
Italia, il valore delle api e la teoria del diritto
La legge 313/04 ’riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine’. (1) Al preciso scopo ‘di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni (…) individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni’. (2)
L’impiego di ‘fitosanitari’ di sorta, durante il periodo di fioritura delle piante mellifere, integra dunque in Italia una sanzione amministrativa, soggetta a penalità che variano da una Regione all’altra. Fatto salvo
il ricorrere del delitto di ‘uccisione o danneggiamento di animali altrui’, la cui procedibilità è vincolata alla presentazione di una querela della persona offesa. (3) Ovvero quello – nei casi più gravi, che l’accusa ha il non semplice onere di provare – di inquinamento ambientale. (4) Dalla teoria alla pratica, sebbene le suddette norme ricevano scarsa applicazione, si può osservare il fenomeno nella sua ampiezza. Per condividere la necessità di introdurre nuove regole.
Salute delle api, i monitoraggi in Italia e in Europa
BeeNet – un programma di monitoraggio della salute delle api sul territorio nazionale, istituito dalla Rete Rurale del MiPAAFT con i contributi di vari enti (IZS delle Venezie, Università di Bologna, CRA, Regioni e ASL) – ha già ampiamente dimostrato l’impatto dei semi ‘conciati’ (trattati cioè con pesticidi) sullo spopolamento delle colonie di api. Il disastro ambientale si disvela grazie al censimento che gli apicoltori contribuiscono a eseguire sui vari territori. Localizzando, con un discreto margine di precisione, le aree colpite da utilizzo improprio di agrotossici. Mediante semina di semi ‘conciati’ (trattati cioè con pesticidi), disapplicando le pur blande ‘precauzioni’ indicate sui sacchi delle Big 4, ovvero irrorazioni incontrollate.
Il rapporto COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes), pubblicato il 30.5.19, è stato realizzato dall’omonima ONG svizzera per indagare lo stato di salute dell’apicoltura. (5) Coloss è un progetto internazionale no-profit, che coinvolge ricercatori da ogni parte del pianeta con l’obiettivo di proteggere l’apicoltura, le api e i consumatori attraverso studi mirati su vari temi, dalla ‘tecnica apistica’ all’analisi dei rischi che minacciano il settore (le patologie, in primis). E la tutela del prodotto mediante adozione di standards di qualità e sicurezza alimentare per combattare le frodi su miele e derivati.
I ricercatori hanno somministrato un questionario a 25.363 apicoltori in 33 in Paesi della macro-regione Europa, oltreché in Algeria, Israele e Messico. Le perdite complessive maggiori, nell’inverno 2017/18, si sono registrate in Portogallo (-32,8%). Perdite superiori al 25% hanno colpito l’apicoltura in Slovenia, Irlanda del Nord, Inghilterra, Galles, Italia, Spagna e Germania. La media europea si attesta intorno al 16%,
La scomparsa degli insetti impollinatori causa danni irreparabili all’ambiente, sia diretti (produzione di miele, biodiversità) che indiretti. Poiché si interrompono gli equilibri delle se catene alimentari naturali, che coinvolgono gli uccelli e i loro predatori. Per mettere fine a questo ecocidio è stata avviata l’iniziativa ‘Salviamo Le Api’, finalmente approdata a Bruxelles dopo un’importante mobilitazione pubblica.
‘Salviamo Le Api’, l’iniziativa dei cittadini europei
‘Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa’ è la proposta d’iniziativa dei cittadini europei registrata dalla Commissione con effetto a decorrere dal 27.5.19. (6) La premessa è lapalissiana, ‘abbiamo bisogno degli insetti per i nostri ecosistemi e per garantire la sicurezza alimentare. La Commissione deve adottare una legislazione per preservare e migliorare gli habitat degli insetti in quanto indicatori di un ambiente incontaminato’.
Gli obiettivi dell’iniziativa sono declinati nei seguenti termini:
– l’Unione Europea deve riconoscere la gravità del problema e attuare una politica effettivamente in grado di porvi rimedio, la quale deve comprendere attività di ricerca e misure regolative. In particolare, bisogna
– ‘individuare alternative, soluzioni anche tecnologiche per ridurre l’uso dei pesticidi,
– vietare senza eccezioni i pesticidi dannosi e riformare i criteri di ammissibilità,
– promuovere la diversità strutturale dei paesaggi agricoli,
– ridurre efficacemente i fertilizzanti (es. progetto Natura 2000),
– istituire efficacemente zone di conservazione (per esempio direttiva quadro sulle acque),
– intensificare la ricerca e il monitoraggio e migliorare l’educazione.’
Si deve superare la storica antinomia tra le posizioni della filiera agricola – sistematicamente disinformata, indottrinata e influenzata dai monopolisti di pesticidi e sementi – e quelle degli apicoltori. Le quali ultime, inevitabilmente, coincidono con quelle dei cittadini più sensibili al presente e al futuro anche prossimo dell’ecosistema. Poiché la sopravvivenza del pianeta e il benessere delle sue creature è un valore che non può venire tradito in nome degli interessi materiali di breve periodo dei singoli. Ed è perciò che abbiamo citato l’esempio dell’apicoltura urbana nelle sue varie forme – a partire dal semplice mantenimento di ‘pascoli per le api’ – quale motore di innovazione sociale.
Le misure da intraprendere, del resto, devono venire condivise sulla più ampia scala geografica possibile. Poiché la biodiversità esprime le ricchezze dei diversi ecosistemi i quali a loro volta comunicano e interagiscono, a prescindere dai confini territoriali. La recente scoperta della volatilità delle microplastiche – in grado di viaggiare migliaia di chilometri per corrompere aree incontaminate e infine ritornare nell’organismo dell’uomo, che vi ha posto causa – offre un esempio concreto di come ‘fare la cosa giusta’. Ogni giorno, a partire dai piccoli gesti quotidiani, servono scelte etiche da parte di tutti.
#Ègalité!
Dario Dongo e Guido Cortese
Note
(1) V. legge 24.12.04 n. 313, ‘disciplina dell’apicoltura’, articolo 1, su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/12/31/004G0346/sg
(2) Cfr. legge 313/04, articolo 4
(3) Cfr. codice penale, articolo 638. ‘Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro’
(4) L’articolo 452-bis del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
– delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,
– di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna
(5) Brodschneider, R., Gray, A., Adjlane, N., Ballis, A., Brusbardis, V., Charrière, J.-D. Danihlík et al. (2019). ‘Loss rates of honey bee colonies during winter 2017/18 in 36 countries participating in the COLOSS survey, including effects of forage sources’. Journal of Apicultural Science. https://doi.org/10.1080/00218839.2019.1615661
(6) Cfr. decisione (UE) n. 2019/847, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0847&from=IT